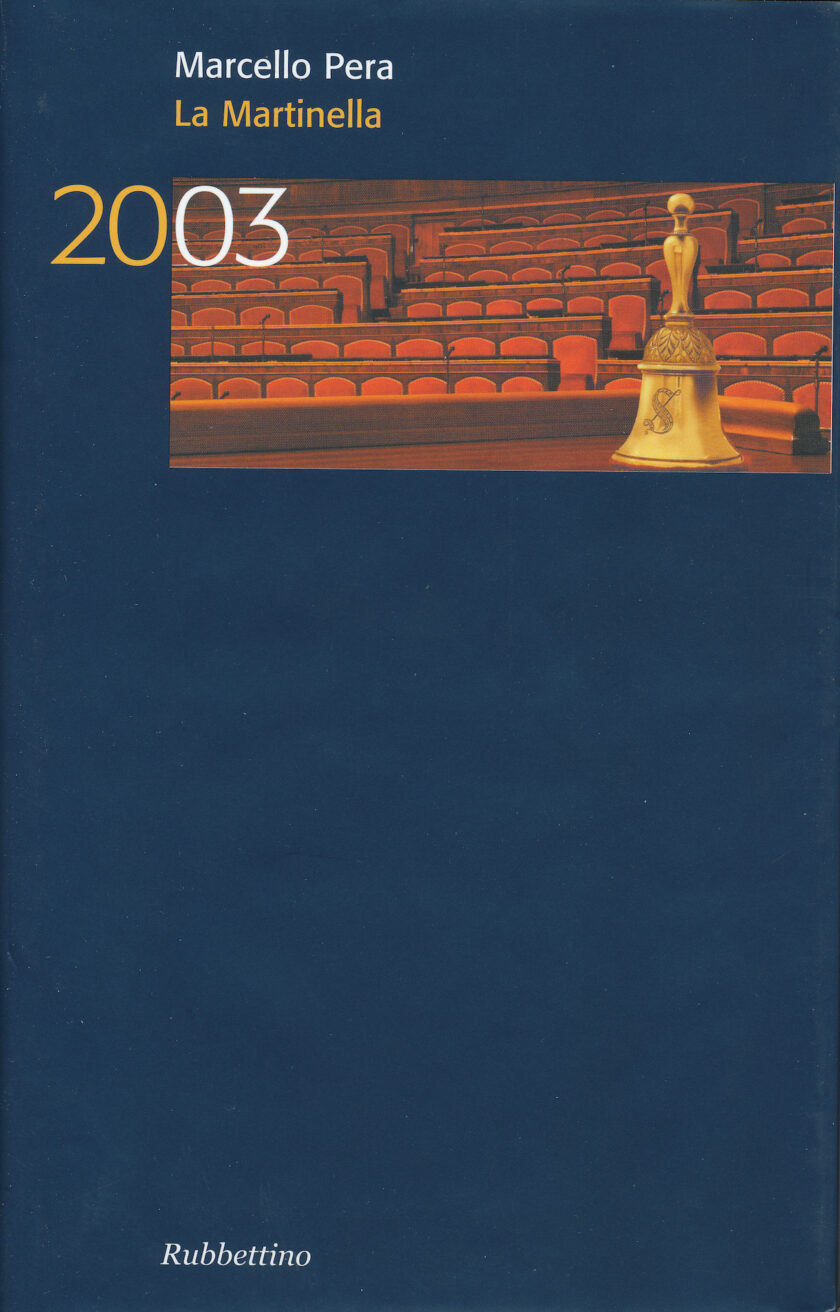Nell’intervento che apre questa raccolta, direttamente, e in altri, indirettamente, richiamo il tema delle conseguenze pratiche delle nostre filosofie. Non è questione accademica, Né è questione da poco.
“Filosofia”, in questo contesto, va intesa in due modi: Uno è quello di teoria compiuta ed espressa, concezione del mondo o di aspetti di esso, dispiegata e argomentata. L’altro è quello di intuizione non professata esplicitamente ma incorporata in atteggiamenti. Nel primo caso, la filosofia è un quadro concettuale articolato, nel secondo è un atteggiamento pratico manifestato. In entrambi i casi, è un punto di vista teorico che giustifica un’azione, una deliberazione, un provvedimento, oppure inquadra e trova una soluzione a un problema.
Ecco perché una filosofia, anche quella apparentemente più distaccata dal mondo, ha conseguenze pratiche. Ed ecco perché è opportuno che le filosofie da implicite diventino esplicite e si possano esaminare e discutere. Perché l’azione surrettizia delle filosofie nascoste rende più difficile la critica e l’esame. Inoltre, quando le filosofie sono nascoste, non per questo le loro conseguenze non si dispiegano; semplicemente, le filosofie nascoste rischiano facilmente di trasformarsi in incrostazioni mentali, ricevute e non più discusse, tramandate e non più esaminate criticamente.
Nella vita politica, esempi di queste conseguenze pratiche delle filosofie sono abbondanti, e ad essi mi riferisco ripetutamente in questa raccolta di interventi.
La filosofia esplicita del relativismo ─ una corrente che attraversa l’Europa e l’Occidente da più di mezzo secolo, e che nella storia del Vecchio Continente ora emerge ora si sommerge come un fiume carsico ─ rischia oggi di mettere in crisi o in serie difficoltà l’identità della nostra cultura e civiltà, e di negarne gli stessi fondamenti. La particolare filosofia della tolleranza, che si è sviluppata in relazione al fenomeno del multiculturalismo sempre più accentuato delle nazioni europee, ha ripercussioni nelle nostre legislazioni sull’immigrazione e sui nostri rapporti con l’Islam e le altre religioni o culture. E la filosofia che i nostri valori sono un insieme ordinabile e gerarchizzabile a partire dal primo che li giustifica tutti (ad esempio, la pace, o la vita) incide sulle modalità della nostra convivenza e sulle decisioni da adottare quando si aprano conflitti e si debbano fare delle scelte in situazioni controverse.
Non minori sono le conseguenze pratiche delle filosofie implicite. Per ricordarne alcune. La tesi ─ che apparentemente milioni di europei hanno bevuto col latte materno ─ secondo cui la guerra è una turbativa di uno stato naturale ha toccato opinione pubblica, governi e parlamenti nel caso del conflitto in Iraq. La tesi che l’Europa sia saggia e l’America selvaggia, l’una perché erede dei Lumi, l’altra perché incline a riportare le fedi religiose o etiche nelle decisioni politiche, ha pesato nelle nostre relazioni euroatlantiche. Sul piano interno, pesa la convinzione che le grandi riforme non si possano fare se non c’è l’accordo di tutti, la quale è frutto della tesi che la democrazia sia un regime di partecipazione al potere e di consociazione nelle decisioni. E, per fare ancora un esempio, la filosofia implicita che anche il diritto allo studio superiore sia un tipo di diritto di cittadinanza pesa inerzialmente sulle riforme del nostro sistema universitario.
Questi esempi si possono moltiplicare e tutti provano che, sempre, se ne sia consapevoli o no, lo si voglia o no, le decisioni politiche, soprattutto le più importanti, sono sorrette da concezioni filosofiche.
Tutte le grandi figure di cui ho avuto modo di fare un ricordo nel 2003, pubblicati in questa raccolta, erano ben consapevoli di questa circostanza del legame fra concezione intellettuale e decisione politica. Dietro le loro parole e azioni, agisce, e spesso si sente prepotente, una fede, un credo, ora laico ora religioso. De Gasperi credeva nella democrazia e nel metodo della libertà; credeva nel cristianesimo come ispiratore di politica; credeva nell’Europa come soggetto politico, economico, morale spirituale; credeva nell’atlantismo come portatore di una medesima civiltà. La Malfa credeva nel mercato, nella competizione, nella liberalizzazione, nella modernità. Marco Biagi credeva nell’ingegneria sociale, una filosofia ben diversa dagli interventi palingenetici; credeva nelle riforme del mercato del lavoro; credeva nella giustizia sociale anche se negava attualità e utilità ai vecchi strumenti e istituti con cui si era cercato di realizzarla; credeva nel potere delle idee e nel confronto fra interlocutori aperti; credeva nella perseveranza quando gli interlocutori erano chiusi o ottusi. E così via, per tutti gli altri.
Non tutte le filosofie, naturalmente, sono uguali; e non tutte, quando si trasformano in azione, danno gli stessi frutti e hanno lo stesso successo. Dei grandi uomini qui ricordati, alcuni vinsero, altri persero; alcuni vinsero in una circostanza e persero in altre. De Gasperi vinse e fondò l’Italia moderna nel ’48; perse nel ’53 con la legge maggioritaria; perse nel ’54 con la Comunità europea di difesa. La Malfa vinse tante volte, sull’atlantismo, la liberalizzazione degli scambi, il mercato comune, e perse tante altre volte. Marco Biagi vinse con la riforma del mercato del lavoro, e per questa vittoria alcuni assassini ideologizzati da altre, escatologiche e violente. filosofie gli tolsero brutalmente la vita. E così, in questa altalena che è la vita politica, vale per tutti.
La tesi delle conseguenze pratiche delle nostre filosofie resta comunque confermata. Qui, fra le molte relazioni pensiero-azione su cui ho avuto modo di soffermarmi, desidero richiamarne due: l’irenismo o l’angelismo che pervade l’Europa di oggi come conseguenza della filosofia della pace, e la crisi di identità europea, come conseguenza della filosofia della tolleranza.
Comincio da questa. Lo spirito di tolleranza nasce in Europa come effetto delle guerre religiose e della lotta di individui e popoli per affrancarsi dai poteri assoluti, in particolare quello del sovrano. La filosofia della tolleranza parte dal presupposto che delle verità assolute, in particolare le verità religiose, nessuna può avere più dignità di altre. Coerentemente, questa filosofia predica un principio politico: che i credi religiosi devono essere confinati nello spazio privato degli individui e non essere portati dentro lo spazio pubblico degli stati. La religione, in questa prospettiva, non può essere uno strumento del regno.
La filosofia della tolleranza è tipicamente una filosofia liberale ed ha avuto benefici effetti ovunque si sia trapiantata, anche se non si può dire che l’Europa, in particolare l’Europa continentale, se ne sia sempre giovata, come mostra la sua storia del secolo ventesimo. Dentro gli stati dove ha messo radici ─ anche quando essi da liberali si sono trasformati in democratici e in sociali ─ essa è diventata un principio sovente sancito costituzionalmente e un sentimento diffuso fra i cittadini.
Quanto sia importante oggi, in un’epoca di pluralismo religioso e di multiculturalismo dentro le nostre società, è facile capire. Ma è importante non fraintenderla, questa filosofia. Tollerare un altro non significa semplicemente prendere atto dell’esistenza e dei costumi dell’altro, della sua cultura, delle sue tradizioni. Poiché con l’altro si deve entrare in contatto, tollerarlo significa prima capirlo e poi confrontarsi con lui. Senza questo confronto, la tolleranza è passiva e sfocia nell’indifferenza. E qui sta propriamente il rischio. Se la tolleranza non diventa un atteggiamento attivo, facilmente degenera. La tolleranza è fatta per tenere assieme individui e per costringerli al confronto, non è fatta semplicemente per aggregare individui e tenerli distinti, ciascuno nei confini della propria cultura.
Insomma, il principio della tolleranza ha bisogno del principio del rispetto. Di ciò ci si deve ricordare nel trattare il problema della immigrazione. La tolleranza non può essere né ospitalità incondizionata da parte dell’ospitante né libertà assoluta da parte dell’ospite. E neppure, come spesso è dato di osservare, può essere intesa come carità. I temi dell’immigrazione e dell’integrazione trattati con atteggiamenti caritatevoli sono destinati a creare problemi maggiori. La carità è un dovere verso il prossimo, ma prima che questo dovere nasca occorre che qualcuno sia il prossimo, cioè occorre che sia tollerato e rispettato e che, a sua volta, tolleri e rispetti.
La tolleranza richiede la reciprocità, richiede che l’ospite e l’ospitante avvertano il bisogno di apprendere l’uno dall’altro, e richiede che entrambi si impegnino attivamente in questo esercizio. Il multiculturalismo si basa su questo impegno. Senza di esso, non produce autentica integrazione, né produce politiche dell’immigrazione efficaci.
Se la tolleranza senza il rispetto degenera in indifferenza, il primo rispetto lo si deve a sé, alla propria cultura. Invece, il relativismo che serpeggia in Europa manca soprattutto di questo requisito. I relativisti predicano la tolleranza come virtù residuale: poiché ─ essi sostengono ─ tutte le culture sono uguali, allora occorre essere tolleranti con ciascuna. Essi dimenticano che il principio della tolleranza, in particolare se accompagnato dal principio del rispetto, vale soprattutto in una cultura, la nostra, che l’ha inventato e sviluppato. Se la nostra cultura non potesse essere giudicata migliore dell’altrui, allora neppure la tolleranza potrebbe essere professata e praticata nei confronti degli altri. Oltre ad autoconfutarsi, il relativismo paralizza l’azione. Apparentemente, professa un atteggiamento aperto e disponibile; in realtà, pratica un atteggiamento remissivo che provoca più tensioni di quante ne voglia evitare.
Soprattutto l’Europa oggi soffre di questa malattia. E il segno rivelatore si è visto nelle discussioni sulla guerra e sul suo atteggiamento nei confronti dell’intervento in Iraq. Le idee che la guerra non si debba mai fare, che ogni intervento armato debba essere bandito, anche quando si è bersagli di atti di guerra da parte di fanatici dell’Islam, che la democrazia non debba essere esportata, nascono da una filosofia che non ritiene più di avere buoni argomenti per difendere la propria cultura. Con un atteggiamento, oltretutto, contraddittorio. Perché mentre, da un lato, l’Europa si atteggia da saggia appellandosi alla cultura dei Lumi, la cultura europea, dall’altro lato, elegge a proprio bersaglio proprio la stessa cultura dei Lumi e la accusa di essere etnocentrica, egemonica, dogmatica, perché sostiene che esiste una realtà, una verità, una ragione, un’essenza del buono, del giusto e degli altri valori.
La crisi dell’Europa, le sue divisioni interne, la sua polemica con l’America, le sue difficoltà con l’integrazione politica, la sua scarsa consapevolezza del rischio del fondamentalismo islamico, si spiegano anche così. E si spiega così anche il rifiuto dell’Europa a riconoscere le radici giudaico-cristiane che l’hanno tenuta a battesimo, e che oggi sono considerate o una minaccia alla laicità dello Stato, come se uno Stato potesse sopravvivere senza una propria identità morale e spirituale, o un segno di egemonia priva di autentici fondamenti.
Far venire in luce queste filosofie, prenderle in considerazione, esplicitarle e criticarle quando sia il caso, è anche questo un contributo che si può dare ai temi più caldi della nostra vita politica.
Per l’aiuto prezioso che mi hanno dato per la stesura degli interventi del 2003 qui raccolti e per il clima stimolante di confronto intellettuale, ringrazio i miei collaboratori. Senza la cura attenta e competente di Dianora Citi, il volume non sarebbe potuto uscire. A tutti sono molto grato.